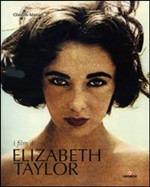 ELIZABETH TAYLOR
ELIZABETH TAYLOR
di Claudio Manari (Gremese, Roma 2010, pp.175, 27 euro)
7 mariti, 64 film, 215 apparizioni televisive, 37 interventi chirurgici, alcuni dei queli eseguiti in condizioni disperate. Il volume delle “Stelle filanti” dedicato alla diva dagli occhi viola comincia subito snocciolando una serie di numeri. E tra i molti dati che offre, ci ricorda anche che la madre di Elizabeth Taylor è morta non molti anni fa, nel 1994, alla bell’età di 98 anni: si chiamava Sarah Viola Warmbrodt ed era stata fondamentale per la carriera precoce della figlia, in quanto aveva riversato su di lei le proprie frustrazioni di ex-attrice teatrale costretta ad abbandonare le scene a trent’anni, subito dopo il matrimonio.
La struttura del libro è quella consueta: un breve capitolo biografico introduttivo, seguito da dati, trame e breve antologia critica film per film. Dall’esordio a dieci anni in There’s One Born Every Minute (1942), al primo successo di Torna a casa Lassie (1943), fino alle ultime apparizioni (come I Flintstones, 1994, quando in fondo aveva appena 62 anni). Tra le curiosità, le principali doppiatrici (Germana Calderini, Fiorella Betti) e un elenco di progetti non realizzati: doveva apparire in Il ragazzo dai capelli verdi di Losey, Quo vadis? nel ruolo poi andato a Deborah Kerr (ma la Taylor vi apparve come comparsa, mentre si trovava in viaggio di nozze a Roma), Vacanze romane nel ruolo poi di Audrey Hepburn, La Regina vergine (Jean Simmons), La ragazza dei quartieri alti (Shirley MacLaine), Questa ragazza è di tutti (Natalie Wood) ecc. Ma anche con dettagliate informazioni mediche sull’ininterrotto susseguirsi di problemi alla schiena, polmoniti virali, interventi chirurgici, intossicazioni da antibiotici, alcool, farmaci e droghe, oltre alla bulimia che a 45 anni la portò a pesare quasi ottanta chili…
 Open Cinema. Scenari di visione cinematografica negli anni ‘10
Open Cinema. Scenari di visione cinematografica negli anni ‘10
A cura di Emiliana De Blassio e Paolo Peverini (ed.Fondazione Ente dello Spettacolo, Roma 2010, pp.256, euro 14.90)
Che ne sarà del cinema e dei film nell’era di Internet? Secondo gli autori, il pubblico della rete diventa sempre più protagonista e sempre meno spettatore passivo, smarrisce l’unità del film per percepirlo in modo frammentario, interviene per reinventare sequenze sperimentando attivamente la propria creatività e la propria riflessione critica. Attraverso una serie di contributi di taglio accademico, il volume cerca di mappare la nuova condizione del cinema “open”, del film come opera aperta che vede la partecipazione dei “pubblici creativi del nuovo scenario cinematografico”. Con riflessioni sul downloading, il reworking audiovisivo, il fansubbing, la peer production, il fenomeno Machinima. Ed esempi concreti, come l’analisi delle varie rielaborazioni in rete di Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. Articoli di Paolo Peverini (“La manipolazione filmica come consumo creativo”), Emiliana De Blasio (“Pubblici creativi nella nuova fruizione cinematografica”), Agnese Vellar (“Il fansubbing e le motivazioni della peer production”), Donatella Selva (“Open Marketing?”) ecc.
 Paradise Now! Sulle barricate con la macchina da presa. Cinema e rivoluzione negli anni sessanta e settanta.
Paradise Now! Sulle barricate con la macchina da presa. Cinema e rivoluzione negli anni sessanta e settanta.
di Maurizio Fantoni Minnella (Marsilio, Venezia 2010, pp.171, sip)
Il libro ripercorre una serie di rapporti e di intrecci tra il cinema e il Sessantotto, visto come “essenzialmente una rivolta e non una rivoluzione, rivolta dei figli nei confronti dei propri padri, dello spirito dell’adolescenza rispetto a quello dell’età adulta”. Nei vari capitoli vengono rievocati i movimenti delle varie “nouvelle vagues” europee che hanno rivoluzionato il linguaggio cinematografico negli anni precendeti il ’68; gli esempi di cinema militante, l’esperienza di Godard e quella dei Cinegiornali liberi di Zavattini; il gruppo di film italiani attorno al ’68 (Bellocchio, Bertolucci, Ferreri, Cavani, Samperi ecc.); i tentativi di affiancare le lotte operaie; la dimensione internazionale dalla Nova Vlna cecoslovacca al Cinema Novo brasiliano, al Che e alle tendenze terzomondiste; e poi l’influenza del cinema americano, l’importanza della dimensione musicale (Woodstock ecc.), le riflessioni successive da Les Amants règuliers di Garrel a The Dreamers di Bertolucci. Sempre ricordando che vi sono essenzialmente due grandi direzioni: quelle di un cinema che in nome del ’68 cerca di rivoluzionare radicalmente le strutture linguistiche e produttive; e quello che cerca di raccontare il ’68, le lotte e la società senza allontanarsi dai metodi di un cinema narrativo tradizionale.
 John Woo. La violenza come redenzione
John Woo. La violenza come redenzione
di Marco Bertolino e Ettore Ridola (Le Mani, Recco, 2010, pp.160, 14 euro)
Nuova edizione completamente rivista e aggiornata della monografia su John Woo pubblicata nel 1998: con un saggio introduttivo, e un’analisi film per film che arriva al sottovalutato Windtalkers, al bistrattato Paycheck e al rientro in patria per il kolossal La battaglia dei tre regni. E con un’intervista realizzata nel 2010, in cui John Woo ribadisce il suo amore per le commedie (“mi sono sempre piaciute, apprezzavo il buon umore che sapevano trasmettere e hanno influenzato i miei lavori futuri”), l’importanza fondamentale del musical come modello per le sue scene d’azione e i problemi incontrati per Paycheck, in cui era poco interessato alla parte fantascientifica e avrebbe voluto sviluppare maggiormente il suspense hitchcockiano. Ricorda anche l’origine della sua firma: “A Hong Kong ho frequentato una scuola elementare cattolica e a nove anni mi sono fatto cristiano. In dialetto cantonese il mio nome è Ng Yu Sam. L’insegnante di inglese faceva fatica a pronunciare i nostri nomi e ci ha suggerito di adottarne uno cristiano: a me piaceva molto la storia di San Giovanni Battista cosicché ho scelto John. Nel 1973, quando ho cominciato a lavorare come regista per la Golden Harvest, un dirigente mi ha suggerito di utilizzare la pronuncia di Shanghai del mio nome, Woo appunto, poiché la Golden Harvest era diventata una compagnia internazionale e gli stranieri avrebbero incontrato difficoltà a pronunciare “Ng”. Così ho cominciato a utilizzare il nome di John Yu Sen Woo, alla fine abbreviato in John Woo”.
(di Renato Venturelli)
 Se pensate che non sia possibile immaginare vicende più reali della realtà stessa, ricredetevi. Le trecento pagine di A schermo nero, di Marco
Se pensate che non sia possibile immaginare vicende più reali della realtà stessa, ricredetevi. Le trecento pagine di A schermo nero, di Marco
Ercolani (1), per intero giocate all’insegna di un supposto “la fiction dépasse la réalité”, scrivono una singolare e intrigante storia “critica” del cinema. Quanto meno, di quella sua parte, in particolare, che si è sbobinata affermando l’estetica “noir” dei B-movies anni Quaranta.
Apocrifando corrispondenze, lettere di addio, registrazioni, ricordi, diari, l’Autore, di professione psichiatra e scrittore, nonché cinéphile, si offre l’occasione per rivisitare la spesso ignorata (o svilita) avventura di una produzione senza dubbio limitata nei budget e obbligata a tempi veloci di realizzazione, ma nel complesso oltremodo significativa per gli autori e le opere che ha radunato. Un cinema che ha raccontato la parte buia di noi stessi, guidato – come Ercolani fa dire a qualcuno dei suoi dialoganti – da una regola incontestata: “il cinema non ha la chiarezza di una visione, è qualcosa di corrotto, di viscerale”.
Scorrono così, lungo le quattro parti in cui è spezzato il racconto, titoli come La neve rossa, L’occhio che uccide, Freaks e i nomi di Edgar Ulmer, Tod Browning, Anthony Mann; persino quello di Maxwell Shane, il regista che ha amato le città, gli scorci notturni mutati in angoli d’incubo, o di Samuel Fuller irremovibile nella convinzione che sullo schermo “il falso deve diventare vero”. Ed è appunto in questo costante gioco (col lettore) di falso e di vero, di ipotizzate conferenze, materiali inediti, dichiarazioni, che lo sguardo critico di Ercolani si dichiara senza possibili ambiguità.
Uno sguardo lucido, attento, frutto evidente di una lunga e partecipata consuetudine con il buio della sala, che gli consente di ampliare l’analisi oltre l’amato noir e l’altrettanto corteggiato versante dell’onirico, per giungere alle attuali presenze di Tarantino, Cronenberg, Carpenter, Coen, Eastwood. Con però preziosi salti all’indietro a “rileggere” Vigo, Murnau, Lang, Bresson, Ophüls, Buñuel, Welles.
(1) – Marco Ercolani, A schermo nero, QuiEdit, Verona-Bolzano 2010, 300 pagine, – € 21,90
(di Claudio Bertieri)
















